Cosa significa vivere la nonviolenza? È la domanda che fa da intercalare nella vita quotidiana di un Casco Bianco. Nonviolenza è una parola che a una prima, immediata, lettura risulta intuitiva, quasi autoesplicativa. Ma poi ci si trova di fronte alle situazioni concrete, che ti chiedono di scendere dalle nubi dell’astratto e tradurla in azioni. E qui, il Casco Bianco che vuole riflettere sul modo più coerente di agire nel rispetto dei principi per cui è partito per una terra lontana, ha dei bei grattacapi da risolvere. Quali sono le basi teoriche per un agire nonviolento? Quali sono i principi che lo guidano? Non sono domande facili a cui dare una risposta. Il pensiero nonviolento ha una lunga storia, e spesso non tutti i sui principi sono così chiari, intuitivi, e coerenti. Ce ne sono di più stringenti, di più forti, di prioritari e non; si possono interpretare in modo più rigido, più flessibile, più ideale o più pragmatico. Con il rischio di rimanere paralizzati, e tornare alle più popolari azioni di risposta ai problemi, che con la nonviolenza non hanno nulla a che fare.
A volte, però, la provvidenza ti fa scivolare dentro la valigia un piccolo libro, che proprio a queste intense problematiche tenta di dare qualche timida risposta, almeno sul piano dei principi. È un libro che tenevo nel cassetto, e che mi ha accompagnato in questi primi mesi di servizio civile. Ho trovato in esso molti spunti, che vorrei condividere in questo scritto, sperando che possano essere uno strumento di riflessione per gli attuali e futuri Caschi Bianchi, ma anche per tutte le persone che si lasciano interpellare da quegli interrogativi. Prenderò ispirazione, quindi, dal testo La filosofia della nonviolenza. Maestri e percorsi nel pensiero moderno e contemporaneo (AA.VV., Cittadella 2006), attingendo a piene mani dal pensiero di Kant, Ghandi, Lévinas e Capitini, che in questo libro viene esposto. Cercherò, per quanto possibile, di presentare ciò che più mi ha colpito, facendolo diventare la cornice di senso di ciò che vivo nella quotidianità, nella mia esperienza di condivisione in una Comunità Terapeutica dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, che racconterò nelle sue dinamiche principali.
Quei volti incancellabili
Partiamo proprio dalla Comunità Terapeutica… Un luogo dove si sperimenta tutta la contraddittorietà dell’essere umano. Qui s’incontra la vita rinata di alcune persone, il loro sorriso, le loro speranze, la loro forza di lottare contro un male – la tossicodipendenza – tra i più difficili da lasciarsi alle spalle. Ma s’incontra anche la vita di chi non ce la fa, i volti di chi ha lasciato. Sì, perché il Centro Terapeutico fa percepire con forza il paradosso della libertà: entri volontariamente, perché non esiste l’obbligo di curarsi se sei tossicodipendente, e con la stessa facilità con cui si entra si può anche uscire, quando la sostanza chiama, quando le illusioni mentali che ti sei costruito ti nascondo la debolezza che ancora ti porterà a ricadere, quando cade la maschera e rimani solo tu e i tuoi veri problemi, le sofferenze antiche che non hai affrontato (P. Rigliano, Doppia diagnosi, Cortina 2004), e l’ansietà che deriva da questa verità ti spinge a scappare. Libertà dunque, che ti crea e ti distrugge. E purtroppo qualcuno esce dal percorso terapeutico… Perché non regge l’astinenza, perché non regge la vita di comunità, perché non regge il mettersi a confronto con quelle dinamiche psicologiche che l’hanno buttato in mezzo a una strada, e che di nuovo lo spingono a mollare tutto e ritornare fuori.
In questi momenti, anche il Casco Bianco più temerario può entrare in crisi, perché è umano, per chiunque abbia un minimo di sensibilità, avere grandi difficoltà ad accompagnare le persone alla porta, anche quando è costretto a farlo. In questi momenti forti, i volti ti s’imprimono in modo indelebile nella mente. Un volto come quello di Carlos (nome di fantasia), che ti prende in disparte, per salutarti e dirti che ha apprezzato il tuo gesto di venire in una terra lontana e metterti al servizio di molte persone, che ti dice che deve uscire dal Centro perché è vecchio e deve cercare di riallacciare i rapporti con la famiglia, perché sente che il tempo passa… Quella faccia non la dimentichi. Non la dimentichi, perché ormai si è saldata all’immagine successiva, che si presenta solo due giorni dopo, di Carlos disteso addormentato davanti al Dormitorio, sporco e ubriaco, di nuovo ricaduto nel suo abisso. È un pugno nello stomaco che non si cancella. Aveva raccontato frottole? Oppure le sue intenzioni erano sincere, ma poi la sostanza di consumo è tornata prepotentemente a cancellare la sua volontà? Si sa, la sostanza spesso porta alla dissoluzione del soggetto, perché ne crea un altro in simbiosi con essa (A. Correale, Il soggetto nascosto, FrancoAngeli 2013), e Carlos l’aveva lasciata da poco più di un mese… Troppo poco per vincere i suoi tentacoli. Si poteva fare di più per convincerlo a restare?
Lo stesso è successo a Luis, un signore conosciuto nel Centro, al quale ti trovi, il mese seguente, a dare un thè e un panino, ogni venerdì nel Servicio Calle – durante il quale incontri i senzatetto di notte nelle zone più abbandonate della città, invitandole ad andare al Dormitorio e condividendo con loro qualche minuto e qualcosa da mangiare – trovandolo ubriaco, sporco, confuso, a dormire nel marciume.
Il volto di Javier, accompagnato alla porta portandogli le sue poche borse di vestiti, perché aveva una stampella permanente. Voleva uscire, ormai la decisione era presa. Anche lui anziano, con famiglia… Ma le lacrime che gli bagnavano gli occhi, sulla porta, mozzavano il fiato. Allora balbetti appena un “Buena vida”, per poi scappare in camera, perché anche i tuoi occhi cominciano ad essere lucidi. Il volto di Juan, duro, scontroso… Che prima s’incazza perché lo privi di una sigaretta per la sua mala condotta, ma dopo un’ora ti viene ad abbracciare. Sai bene che rientra nelle strategie manipolative che si è costruito per sopravvivere… Eppure un abbraccio è sempre un abbraccio. E quello di Alejandro, che non ha un dente sano, ma ride, scherza, ti abbraccia come nessun altro. Gli occhi di Miguel, quando siamo andati a festeggiare il suo compleanno a casa della sua “abuelita”. Se lo meritava, perché si stava comportando molto bene. Lo accompagni con un operatore, e ti trovi in una casetta fatta di lamiere e pezzi di legno, dove l’accoglienza è però davvero grande. C’era la sua nonnina, e anche la mamma era giunta da Santa Cruz per festeggiarlo. È stato bello vedere i gesti di affetto di Miguel verso sua madre… eppure… Eppure sai bene che Miguel è nella Comunità perché la madre e il padre lo hanno abbandonato dalla nonnina, perché i genitori sono alcolizzati e non hanno saputo dargli ciò di cui ogni bambino ha bisogno. Nei racconti di Miguel – che si agita, si prende i capelli, insofferente, quando racconta certi eventi dolorosi – scorgi quell’ancestrale sofferenza che in questo Centro siamo chiamati a curare, perché non lo porti di nuovo a cercare nella sostanza “l’unica cosa che mi faceva sentire felice e in pace”, come lui stesso ti racconta.
Ma in Miguel, quel giorno, non agivano le forze del risentimento e dell’odio: le carezze e i baci alla mamma seguono un’altra logica, quella dell’amore – sì, della nonviolenza – che ti lascia attonito, a guardare. Miguel non ha ancora perdonato, non ha ancora superato i conflitti passati con i genitori, ma oggi ha deciso che nella costante polarità di odio-amore che vive nelle sue relazioni familiari, doveva prevalere l’amore. Resti attonito e senza parole anche di fronte alla dignità della sua nonnina, con le mani consumate dal lavoro, un sorriso ormai senza denti, ma con una tenacia e un’allegria contagiosa. Sai che ha fatto molti sacrifici economici per cucinare quel pollo. Aveva un sapore di affetto e ospitalità – altro nome della nonviolenza – che mi resterà impresso.
E la pancia gonfia e dura di Andres, i suoi occhi gialli, ormai spinto verso gli ultimi respiri dalla cirrosi. Incontrato più volte sulla strada, durante il Servicio Calle, che sempre ti chiede, sorridendo: “Siete riusciti a scovarmi anche stanotte, dove mi posso nascondere?”. Poi ti parla, ha molto piacere di chiacchierare. Ma non vuole farsi aiutare, perché non vuole più molestar nessuno. Forse nella vita troppe volte è stato rifiutato. Arriverà a riporre in noi la sua fiducia? “Torneremo”, gli abbiamo promesso. Ma l’ultima volta non siamo riusciti a trovarlo sulla strada. Era già in ospedale. “Anche qui mi avete trovato”, ci ha detto sorridendo il giorno dopo, da quelle lenzuola sporche del reparto, nudo, al freddo. Gli occhi si stavano spegnendo. L’abbiamo visto in tutto tre volte… Erano troppe poche? O erano sufficienti perché, per un attimo, si sia sentito cercato, voluto?
Sono casi come questo che ti mettono di fronte al senso del limite e dell’impotenza: un’associazione non ha mezzi infiniti, la medicina non è onnipotente, le nostre forze – anche quelle del bene – sono condizionate e spesso contingentate. Siamo spesso, purtroppo, “solo” dei palliativi. Quale logica, allora, ci impone di perseverare, di continuare a credere che vale sempre la pena di coltivare ogni piccolo germoglio di bene?
Di fronte al limite
È di fronte a tutti questi volti e queste situazioni che ti ritornano alla mente tutte quelle domande sulla nonviolenza, magari nel riposo di un giorno di Pasqua. In questa realtà difficile può venire spesso da chiederti: qual è la verità della nonviolenza? Perché la nonviolenza deve essere il nostro stile di vita? Cosa può fare, di realmente efficace, un Casco Bianco?
Qui si fa davvero l’esperienza del limite dell’uomo, limite nel progettare, nel costruire, limite nel gestire la propria vita, i propri labirinti psicologici, che a volte s’infrangono nell’alcool e nella droga. Limite dell’abbandono e della falsità, dell’autoinganno che ti butta sulla strada, limite del linguaggio che non sa raccontare un trauma nascosto. Limite che in fondo culmina nella morte. Però è proprio nello schiantarsi contro questo limite, questi limiti, che l’uomo percepisce quel qualcosa di ulteriore, percepisce che l’uomo non è quel limite. In fondo è proprio qui, nell’attimo in cui sfioriamo l’idea della morte, che viviamo la nostra verità più profonda: noi non cediamo alla morte, in tutte le sue forme. La morte non può annullare la vita, perché la morte non può annullare la persona, mai. Nemmeno la droga può farlo, anche se è difficile togliere dalla testa di un alcolizzato la frase “Soy un alcohólico y siempre será así”. Come possiamo entrare in queste dinamiche psicologiche e fargli riscoprire la dignità di essere una persona – con problemi di consumo di alcool, certo – e che una speranza c’è sempre?
Se non cediamo e non crediamo alla morte – nemmeno quando ci tocca da vicino, perché siamo convinti che mai la persona si cancella, nemmeno dopo l’ultimo respiro – allora crediamo alla vita: nelle nostre viscere è questo che ci sostiene, è questo che ci fa agire secondo le leggi della vita. Il pensiero nonviolento cerca proprio di scoprire queste leggi, a partire dalla ferma convinzione che la morte – anche quella lenta di ogni giorno – non è la verità del mondo. Le trova nella creatività e la nonviolenza, la non-distruttività. Perché, mi sussurra il mio libriccino, il contrario della morte non è solo la vita, ma anche il non-lasciar-uccidere e per non lasciar uccidere c’è un’unica via: quella della costruzione sociale, della politica, dell’economia della giustizia, la via della costruzione di condizioni umane in cui nessuno debba aver paura. Questa è la via del coraggio e della forza del bene, che è sempre liberante, e che coincide principalmente con la condivisione con gli ultimi per contribuire a liberarli: è porsi dalla parte delle vittime, dei violentati. Qui, in questo, la nonviolenza dispiega la sua grande efficacia. Una via, quindi, che può prendere le forme umili di uno zaino, in spalla di un volontario che parte per un paese straniero per un anno e si trova in un Centro Terapeutico per non-lasciar-morire un gruppetto di ragazzi che sono vittime di un sistema, che egli non ha il potere di cambiare da solo. Non può che essere una minuscola goccia, ma anche una goccia disseta e può contribuire a spegnere un incendio. Non lasciar morire, letteralmente.
Avete mai sentito l’odore della morte? Io no, ma qualcosa di simile forse sì. Ricordo come se ce l’avessi qui a fianco l’odore di Ken, quando mi si è seduto accanto nella cappellina del Centro, il giorno che è rientrato dopo qualche mese fuori a bere. Non era la puzza di chi non si lavava da mesi, ma quella di chi ha sfiorato la putrefazione (e l’aveva fatto davvero, almeno il suo braccio, dopo il morso di un insetto). Eppure dovevo riuscire a sentire, anche nell’odore di morte per la morte, l’odore di vita per la vita, per poterlo essere anch’io (Lettera ai Corinzi – 2Cor 1, 15-16). Dovevo credere, ancora, che la morte non aveva avuto l’ultima parola.
Una delle forme della nonviolenza, allora, è il non-lasciar-uccidere, è il non-cedere-alla-morte: questa è la sua verità. La nonviolenza, trovo scritto nel mio prezioso libriccino, è un’attitudine essenzialmente positiva nei confronti del reale e di ogni persona, è vivere la gioia che l’altra persona esista, creando le condizioni perché ciò avvenga, difendendo e sviluppando la realtà di tutti. Facile e bello, a parole. Però può capitare di trovarsi a dover sostenere l’arduo compito di non lasciar morire un’intera realtà, una serie di progetti, una rete di relazioni tra le persone che non sono come te le aspettavi. Anche nelle realtà del volontariato a volte si annidano rancori, superbia, carrierismo, incomprensioni… Che significa nonviolenza qui? È sempre molto difficile rispondere a questa domanda, ma forse un’azione nonviolenza, in questi casi, è primariamente quella di non fomentare certe dinamiche – con l’antica arte del silenzio, perché a volte l’amore ha questa forma, quando le parole possono ferire – oppure esercitare una sapiente opera di ricucitura dei rapporti, a volte denunciando apertamente certi errori, a volte aiutando le persone a perdonare. Nonviolenza è non-lasciar-morire, ma anche non-lasciarci-morire, che in fondo significa non lasciare mai che la speranza abbandoni il nostro sguardo sulle cose, in primis su noi stessi. Perché una certa sapienza insegna che due sono i peccati contro lo Spirito: distruggere la libertà dei figli di Dio e rinnegare la speranza nella Provvidenza di Dio.
Può capitare di trovarsi a lavorare con persone che ti urtano i nervi solo passandoti accanto. Siamo pur sempre uomini, con la nostra pancia ricca di emozioni forti. Nonviolenza qui significa porre in silenzio la pancia, e far parlare la riflessione razionale, che ti pone di fronte al volto di queste persone con una domanda precisa: “Cosa posso fare, nel mio piccolo, per far fiorire queste persone, per creare energie positive anche da questi incontri?”. In fondo, non ce la stanno mettendo tutta anche loro per promuovere il bene, pur con tutti i loro limiti?
L’incontro, sposo della condivisione
Sposo della condivisione è l’incontro. Un’esperienza di servizio civile come Casco Bianco accentua quella realtà umana che è il trovarsi di fronte a migliaia di Altri-diversi-da-noi. L’accentua perché, con quelle persone, ci vivi a fianco tutti i giorni e tutte le ore, sperimentando sulla pelle l’altro grosso paradosso che ci segna da quando nasciamo: siamo chiamati ad essere sostanza e relazioni (proprio come la Trinità), a recintare costantemente il nostro Io-sostanza, pur essendo ogni secondo proiettati – che lo vogliamo o no – in un mondo di relazioni che quell’Io lo dilaniano, lo modificano, lo ricreano. Con la conseguenza che la barriera tra Io e Altri diventa sottile, quasi impalpabile. E nonviolenza è proprio sapersi in profonda relazione con ogni altra persona, un’unione indissolubile che non annulla mai la individualità di ciascuno. Far sì che queste relazioni interpersonali siano nel segno dell’amore, allora, è ricreare sulla terra la forma di relazione propria di Dio: quella delle Persone della Trinità, unite in un vincolo d’amore che le fa essere Unità, pur senza mai dileguare la singolarità di ciascuna Persona.
Ogni altra persona. Come i ragazzi di strada, giovanissimi e iperattivi, un po’ strafottenti, ma allegri. Può capitare di restare rapiti dal loro sguardo, cercando di guardare più a fondo nei loro occhi. Sorprende, infatti, la loro apparente allegria. Sembrano felici così come sono… Ma lo sono veramente? Oppure è un allegria temporanea, data dalla droga, dalla giovane età, che nasconde in realtà un disagio profondo? Un disagio non detto, negato: quel malessere, misto a noia, risentimento aspecifico, inquietudine, rabbia, delusione, di cui tanto sentiamo parlare (A. Correale, Disfarsi di Sé. Angoscia borderline e uso di sostanze) e che loro esprimono continuamente con il termine aburrimiento. E perché scappano non appena la relazione – o transfert – che si crea con loro si fa un po’ più sincera? È presto per poter rispondere, e forse non rispenderò mai a queste domande… Qui come nel Centro, il senso di smarrimento che coglie l’operatore di fronte ai tossicomani – ai loro modi di agire, di relazionarsi – si tocca con mano, e si somma alla mancanza di una visione teorica e clinica universale, in grado di applicarsi ad ogni singolo caso. Smarrimento che è però anche sfida e fascino, che chiede creatività nell’intraprendere percorsi di vita con il tossicodipendente, perché l’incertezza terapeutica è dovuta a quella soggettività insondabile che sta alla base dell’interpretazione della sofferenza vissuta – e mai riconciliata – che la sostanza cerca, a suo modo, di curare. Ambiguità maligna di una cura che, mentre dona un momento di sollievo all’ansia, all’angoscia e al non-senso, nel profondo ti distrugge.
Certamente fa un certo effetto camminare nella piazza centrale e incontrare loro – i ragazzi di strada, la maggior parte delle volte strafatti – che sono lì per lustrare le scarpe ai ricchi, con le loro scatolette, lo straccio, e il lustrascarpe. Fa un certo effetto vederli inginocchiati di fronte ad un adulto – nella posizione che richiama antropologicamente la supplica e la sottomissione – a pulire delle scarpe, ma fieri di farlo, perché con quei due boliviani che guadagnano si sentono indipendenti… e felici. Fa un certo effetto, perché noi siamo abituati ad andare in piazza e incontrare la “parte bene” della città, le nostre amicizie più o meno altolocate. Qui, invece, di tutta la città, noi conosciamo gli ultimi e con questi ci fermiamo a parlare davanti ai bar, dove tutti prendono il caffè e mostrano la loro ricchezza. Fa strano, molto strano. Ma ti fa sentire al tuo posto, soprattutto se li fai sedere al tavolo con te. Non possiamo costringerli a lasciare il loro lavoro e la loro “presunta” felicità. Possiamo solo accompagnarli e permettergli di vivere la loro realtà nel miglior modo possibile. E quando ti salutano dicendoti “hermanito”, in fondo capisci cosa stanno cercando e ciò da cui scappano: una relazione autentica.
La responsabilità dell’Amore
Da questa interrelazione che ci segna nasce il compito della responsabilità, il compito di creare un mondo all’altezza dell’Amore – sì, proprio quello trinitario – che parla di una Persona che è tale perché la sua sostanza è una relazione fra tre Persone. Responsabilità che si deve applicare sia rispetto all’obiettivo, sia rispetto ai mezzi per raggiungerlo. La pace, la nonviolenza, è il fine che i Caschi Bianchi perseguono, ma anche il mezzo per raggiungerlo. Anche quando, a prima vista, risulta non essere il più vantaggioso. Condividere con gli ultimi a volte sembra una perdita di tempo, perché non crea cambiamenti immediati: quando un ragazzo entra per la terza volta nel Centro Terapeutico, dopo altrettante ricadute nel consumo, ti chiedi se quel che stai facendo è la cosa più utile. Sapendo che ci sono precise responsabilità politiche ed economiche per la situazione che questo ragazzo sta vivendo, ti viene frequentemente l’idea di andare a cercare i responsabili e farli fuori. A volte sembra più utile eliminare l’avversario, rispondere alla violenza con la violenza. Ma anche il mezzo è condizionato dal principio della nonviolenza: ogni persona va trattata come fine, sempre. Lévinas diceva che la necessità ontologica della nonviolenza è data dall’impossibilità etica della violenza. Al di là della formula complicata, credo che il punto sia chiaro: la violenza è sempre immorale, perché ogni uccisione trasgredisce il principio generale della dignità assoluta della persona.
Ecco perché la nonviolenza non può che essere la verità della realtà, l’unica sua Legge profonda. È un’intuizione anche cristiana: la radice della nonviolenza sta nell’amore senza calcolo, che trova la sua ragione ultima nell’Amore che ci ha scelti prima dei nostri meriti. La nonviolenza come legge fondamentale è quindi la legge che corrisponde all’Amore originario, quello incondizionato, senza calcolo di interesse: l’Amore – chiamiamolo pure Dio – che ha creato il mondo pur sapendo che lo avrebbe rifiutato. Tale sapienza insegna che la legge del più forte, della violenza, dell’odio, del calcolo d’interesse, non è la norma a cui alcune persone straordinarie tentano di porre qualche flebile rimedio. No. La legge fondamentale è l’amore, ed è casomai la violenza a costituire la violazione e una trasgressione di un’architettura positiva. Qui la nonviolenza si rivela come una verità che appartiene alla sapienza umana universale – laica e religiosa – non esclusiva del cristianesimo, ma che, proprio perché universale, ha con esso delle profonde affinità. Con i ragazzi del Centro, durante un laboratorio di “valori”, ho letto una storia che mi ha colpito; scritta da Tolstoj molti anni fa, Cosa fa vivere gli uomini è una raffigurazione della legge fondamentale dell’amore, pur nelle dinamiche più cupe dell’essere umano.
Certo, questo non risolve le aporie del pensiero, che pur riconoscendo la portata veritativa della nonviolenza, si trova a dover affrontare casi limite. Come quello del tiranno che sta per uccidere migliaia di persone: se ho in mano una pistola, e sono alla giusta distanza, prima che lui prema il bottone che sgancia la bomba, posso premere il mio grilletto e fermarlo? Qui si sfiorano problematiche enormi, evidentemente, che hanno primariamente a che vedere con il concetto di sacrificio: fino a che punto il singolo può praticare la nonviolenza di fronte al male? Fino all’estrema conseguenza del suo stesso sacrificio in nome di un principio? Ma lo stesso si può richiedere a una moltitudine di persone, a un popolo (sacrificio collettivo)? Qual è il sottile confine tra passività e nonviolenza? Quando il nemico ha il dichiarato intento di procedere a uno sterminio – come è avvenuto nel passato, ma anche nel presente – le vie della sola nonviolenza sono sufficienti? La nonviolenza è sempre attiva, oppure ci sono casi in cui si configura come una resa al male? Trova spazio, nella nonviolenza, la legittima difesa (individuale e collettiva)? In che forme?
Quante domande si porta in valigia un Casco Bianco, e che si trova a rimuginare il giorno di Pasqua di fronte a una squisita sopa de manì, quelle arachidi portate dalla mamma di un ragazzo del Centro. Ma è ora di chiudere i libri. Non trova molte certezze, il Casco Bianco, neppure qui. Sa solo di trovarsi in un progetto dove si cerca di attuare la nonviolenza; dove, in fondo, si cerca di vivere la Pasqua ogni giorno. Perché che altro è la Pasqua se non la risposta alla morte? Cos’è la resurrezione se non proprio un non-lasciar(ci)-morire? La Pasqua è la risposta della fede al dato antropologico: l’uomo non finisce con la sua morte, l’uomo non coincide con i suoi limiti, perché è chiamato a diventare simile a Dio, agendo nell’amore.


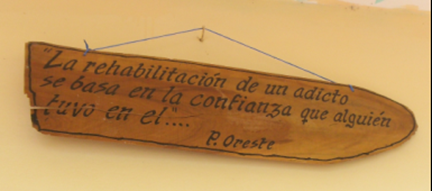















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!